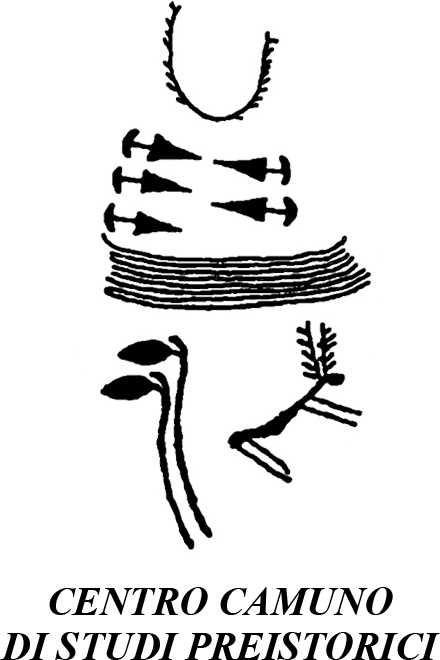
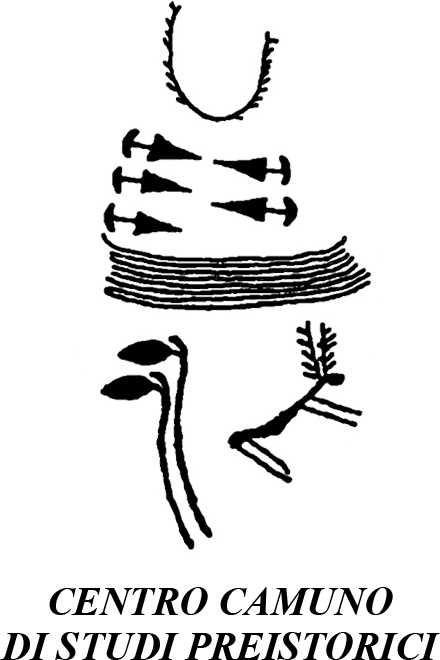
Nella rossa Guida d’Italia, edita dal Touring Club Italiano nel 1914 e curata da Luigi Vittorio Bertarelli, la scheda sulle escursioni fra Breno e Capo di Ponte riporta la prima segnalazione moderna di incisioni rupestri: «In un campo che si incontra prima di giungere alla Pieve, due grossi trovanti con sculture e graffiti simili a quelli famosi del Lago delle Meraviglie nelle Alpi Marittime». Autore della nota, che si riferisce ai massi dell’età del Rame del Pian delle Greppe a Cemmo, era stato Gualtiero (Walther) Laeng, un giovane alpinista, naturalista e geologo, che già nel 1909, in una lettera purtroppo perduta rivolta al “Comitato nazionale per la protezione del paesaggio e dei monumenti” del TCI, si era reso conto dell’eccezionale importanza e dell’estrema antichità delle rocce.
La Prima guerra mondiale sposta il fronte nella parte più settentrionale della Valle e di fatto interrompe la frequentazione della zona da parte degli studiosi. In questi anni, il secondo masso di Cemmo scompare in mezzo alle sterpaglie, tanto che non viene nominato nelle pubblicazioni dell’epoca; si dovrà aspettare il 1930 perché riveda la luce, ad opera di Giovanni Marro.
Durante gli anni Venti, il geologo ligure-piemontese Senofonte Squinabol si rivela una figura chiave per la scoperta e la divulgazione delle incisioni rupestri camune. Squinabol, nella sua formazione, aveva curato i rilevamenti per la Carta Geologica anche nell’area del Monte Bego, esaminando e verificando con cura le incisioni, note da tempo nell’ambito scientifico. Giunto in Valcamonica alla fine della Grande Guerra, si appassiona alle rocce e alla morfologia geologica della valle; stabilisce la sua residenza estiva a Cemmo e si imparenta con Murachelli, il podestà di Capo di Ponte. Squinabol scopre e riconosce diverse incisioni rupestri mentre studia le strie glaciali sulle arenarie camune e, insieme al podestà, suo consuocero, ricerca a Cemmo i massi descritti da Laeng, constatando, nel 1921, l’occultamento del secondo masso. Si adopera, quindi, perché possa essere liberato da sterpaglie e detriti: la sua segnalazione, accompagnata anche da alcuni calchi in gesso, ora scomparsi, resta inascoltata, anche perché la Regia Soprintendenza agli Scavi e Musei della Lombardia, con sede presso la Certosa di Pavia sta per essere sciolta; nel 1924, infatti, la giurisdizione su tutta la Lombardia passa alla Soprintendenza di Torino, dove opera soprattutto l’ispettore Pietro Barocelli, assai attento allo studio e alla documentazione sulle incisioni rupestri, soprattutto per quanto riguarda il Monte Bego.
Giuseppe Bonafini, studioso di Cividate Camuno, nella sua tesi di laurea, La Valcamonica nelle età preistoriche e romana, discussa nel 1927, segnala e descrive anche il masso ancora visibile al Pian delle Greppe. Sull’onda di queste prime segnalazioni, l’antropologo torinese Giovanni Marro, nel 1928, presenta domanda di concessione per effettuare ricerche a Cemmo e dall’anno successivo fino al 1933 effettua regolari campagne in Valcamonica.
Dagli anni Trenta in poi, la silenziosa e costante opera di Giuseppe Bonafini nel campo dell’archeologia rupestre si dipana in un panorama storico complesso, mutevole e spesso difficile: non si può quindi non ammirare questa figura di studioso, per il quale il piacere della scoperta archeologica è sempre accompagnato dalla viva preoccupazione per la tutela del bene e da un’attenzione per la sua divulgazione al pubblico. Nel 1930, nell’opuscolo dedicato al masso di Cemmo, Bonafini riconosce alcune sovrapposizioni e collega correttamente le incisioni ai petroglifi del Monte Bego, ipotizzando che esse debbano risalire ai primordi della vita umana in Valcamonica. In un successivo articolo, corredato da splendide fotografie, descrive Cemmo 1 e Cemmo 2 (nuovamente recuperato); già nel 1932 il Nostro auspicava, con una visionaria intuizione, l’istituzione di un “Parco Nazionale Preistorico” per valorizzare e salvaguardare i gruppi più numerosi e importanti delle incisioni. Nei decenni successivi, la sua attività continuerà indefessa, per portare, negli anni Cinquanta, ad altre notevoli intuizioni scientifiche e a rinvenimenti di grande valore.
Gli anni Trenta, tuttavia, sono ormai noti per l’arrivo in Valcamonica di studiosi illustri, sia italiani che stranieri, ma soprattutto anche per le implicazioni ideologiche che le missioni comportano, con un riflesso decisamente importante, è vero, nell’interpretazione dei petroglifi, ma soprattutto nelle vite dei singoli protagonisti.
Giovanni Marro, antropologo torinese laureato in Medicina e Chirurgia, arriva dunque a Cemmo nel 1929, preceduto già dalla fama di studioso e antropologo; inizialmente convinto, sulla base delle osservazioni stilistiche di Barocelli e di quelle geologiche di Squinabol, dell’antichità delle incisioni di Cemmo, e soprattutto dei pugnali, muterà poi la sua opinione nell’ambito di un vero e proprio conflitto di potere con Raffaello Battaglia, ispettore della Soprintendenza delle Tre Venezie, arrivato nel novembre 1931 per esplorare il territorio. Nel 1929, per una strana coincidenza, su segnalazione di Laeng, viene invitato a esaminare il masso superstite di Cemmo anche Paolo Graziosi: operando uno all’oscuro dell’altro, Marro e Graziosi eseguono schizzi e frottage delle figure e intervengono addirittura in sessioni diverse del medesimo convegno con comunicazioni sul carattere e sulla possibile datazione del ritrovamento; Graziosi, dopo la breve parentesi in Valcamonica, oggetto di una pubblicazione nel 1931, si dedicherà ad altri studi, affermandosi come uno dei più influenti e stimati studiosi di Preistoria nell’Italia del dopoguerra.
Tornando a Giovanni Marro, fu lui ad effettuare lo scavo del secondo masso di Cemmo, finalmente rimesso in luce. L’eccezionale importanza dell’area spinge Ettore Ghislanzoni, insieme a Raffaello Battaglia, a compiere alcuni sopralluoghi, al fine di includere i due massi nella lista dei Monumenti Nazionali e di permetterne la tutela. Antonio Nicolussi, assistente della Soprintendenza delle Tre Venezie, a Giàdeghe, nel territorio di Sellero, vede le prime incisioni rupestri su roccia affiorante. La segnalazione mette subito in moto Marro che, attraverso l’amicizia con Squinabol, con il podestà Giovanni Murachelli e con il grande storico locale don Romolo Putelli, ottiene una numerosissima serie di segnalazioni e, anche grazie alla proficua e preziosa collaborazione con la guardia forestale Longino Amaracco, individua quasi tutte le aree tuttora conosciute della media Valle: nomi quali Naquane (o, per meglio dire, “Nacquane”), Zurla (Salite della Zurla), Foppe di Nadro, Scale di Cimbergo e Scale di Paspardo, Redònt, Cunvài, Niévet compaiono negli scritti di Marro fin dai primissimi anni ’30.
Una mole impressionante di documentazione viene raccolta dallo studioso torinese: disegni, calchi e soprattutto fotografie attestano un’attività ininterrotta e assidua, ben illustrata nelle sue pubblicazioni, più di una trentina, edite soprattutto tra il 1930 e il 1935. Alcune scoperte di Marro segnano una svolta negli studi: ne è un esempio la monografia del 1935, la prima dedicata ad una roccia camuna, sulla “Roccia delle Cinque Iscrizioni” a Campanine di Cimbergo. Nello scritto si affrontano non solo la questione epigrafico-linguistica legata alle popolazioni dell’età del Ferro, ma anche il nodo sull’identità etnica degli utilizzatori dell’alfabeto di tali iscrizioni, alfabeto noto allora come “di Sondrio”. Sull’eccezionale importanza epigrafica del documento si apre un acceso e delicato dibattito che coinvolgerà anche studiosi stranieri e che inevitabilmente, data l’epoca, non sarà scevro da implicazioni etniche. In altri casi, le segnalazioni dello studioso spingono i ricercatori a ritrovare incisioni perdute (come è avvenuto nel caso del carro di Paspardo, riscoperto nel 1999, dopo ben 65 anni dalla sua prima pubblicazione). Decisamente moderni sono il delicato trattamento a gesso con cui vengono evidenziate le figure affinché risultino visibili e l’accurata precisione sia nel campo delle descrizioni, con un’attenta analisi delle sovrapposizioni, che nella topografia, elementi a favore di una solida metodologia scientifica non sempre presente nel rigore delle teorie interpretative, la maggior parte delle quali, oggi, non è più accettabile.
Il novembre 1931 segna, come già accennato, l’arrivo di Raffaello Battaglia, archeologo incaricato ufficialmente dalla Soprintendenza delle Tre Venezie: studioso di assoluto rigore, si avvicina all’esplorazione e alla ricerca con un approccio assai razionale. Nei pochi anni della sua presenza in Valcamonica, descritti con magistrali pubblicazioni tra il 1932 e il 1934, egli illustra notevoli scoperte: prime tra tutte, le rocce con complessi topografici di Bedolina e di Pià d’Ort, correttamente interpretati come campi coltivati alla luce dei confronti con le analoghe figure presenti sul Monte Bego, ma anche le scene di aratura a Seradina (roccia 12). Tra Marro e Battaglia, però, si innesca una polemica, a volte piuttosto pesante, sulla priorità delle scoperte e sull’analisi e interpretazione dell’arte rupestre.
Fino al 1933, le tendenze nazionalistiche e vicine alle tesi del regime fascista sono limitate alla sola affermazione dell’autoctonia della popolazione preistorica; nel conflitto che si instaura con Raffaello Battaglia, Marro abbraccia una cronologia appiattita sull’età del Ferro, portandolo così a “storicizzarle” in chiave di esaltazione della civiltà camuna, da lui avvicinata ai Liguri; in seguito, e in particolare tra 1938 e 1940, sempre più legato al Fascismo, aderisce alle teorie razziali e lega definitivamente l’imponente emporio paletnologico camuno all’idea del primato della razza italica, già fondata sui valori dell’aratro e della spada.
Oltre a rivendicare l’importanza della libertà di ricerca e a criticare pubblicamente Marro sia per il suo atteggiarsi a primo scopritore delle incisioni – primato che spettava, invece, a Laeng – sia per la pretesa di monopolizzare le ricerche che l’antropologo torinese andava cercando tramite i suoi legami politici, Battaglia risponde al collega anche in merito ad alcune sue interpretazioni poco corrette. Marro riteneva, ad esempio, che la civiltà camuna da lui scoperta vivesse su palafitte e fosse dedita a culti delle acque, testimoniati anche dalla raffigurazione di “pagaie” (oggi interpretate come palette); Battaglia, invece, partendo dalla conformazione geomorfologica del territorio, smentiva drasticamente questa ipotesi e sosteneva che le raffigurazioni di capanna potessero essere interpretate anche come granai o fienili, con un’interpretazione sorprendentemente moderna. Tuttavia, l’approccio più scientifico fu, nel conflitto tra studiosi di quegli anni, senza dubbio quello di Raffaello Battaglia.
Malgrado le sue errate convinzioni sugli strumenti utilizzati per eseguire le incisioni, secondo lui tutti metallici, e sulla cronologia, fatta interamente risalire all’età del Ferro, i suoi scritti appaiono ricchi di osservazioni interessanti e pertinenti, spesso ancor oggi valide, sia sulla distribuzione delle rocce incise in relazione alle formazioni geologiche della valle, sia sul raggruppamento delle incisioni in diversi gruppi topograficamente distinti (gruppo di Cemmo, gruppo di Sellero, gruppo di Cimbergo, gruppo di Paspardo). Importanti sono i confronti istituiti con alcuni reperti dell’età del Ferro: è Battaglia a collegare il labirinto della Grande Roccia di Naquane con quello graffito su un’oinochoe (una brocca per versare il vino) rinvenuta nella necropoli etrusca della Tragliatella; è sempre lui a istituire un parallelo tra i cavalli incisi e quelli riprodotti nella pittura vascolare greco-italica e, soprattutto, nei reperti dell’arte delle Situle, che ci ha restituito vasi di bronzo a forma di secchio di grande bellezza, diffusi e prodotti in ambito veneto, etrusco, celtico e germanico. Grazie all’amicizia e alla collaborazione con Bonafini, inoltre, Battaglia correttamente compara le iscrizioni nord etrusche con quelle rinvenute su materiale laterizio della vicina Cividate Camuno. A differenza degli altri studiosi, infine, l’archeologo triestino intuisce anche l’importanza delle incisioni storiche, continuatrici dell’antica tradizione preistorica: sue sono le prime fotografie delle torri merlate, delle chiavi e delle strutture delle Scale di Cimbergo; sue sono le prime ricerche al Monticolo di Darfo, zona nella quale segnala, nella fondamentale pubblicazione del 1934, oltre alle croci, uomini, angeli, motivi floreali, oggetti sacri o brevi iscrizioni; sua è l’attribuzione ad epoca moderna (dopo il XIII secolo) della Casa del fabbro al Pià d’Ort, come parrebbe alla luce degli ultimi studi e confronti. Per finire, entrò discretamente anche nella questione etnografica proponendo l’accostamento delle popolazioni del Ferro con i Camunni citati nelle fonti antiche (sempre in polemica con Marro, che invece li riconduceva a ceppi Liguri). L’ultimo atto della polemica tra i due avvenne in occasione della Mostra della Montagna di Breno, in cui essi presentarono al grande pubblico gli esiti scientifici delle loro scoperte. Successivamente, forse a causa della crescente influenza politica di Marro o perché desideroso di altre esperienze nel campo della preistoria, Battaglia smise di occuparsi dell’arte rupestre e, nello stesso anno 1937, iniziò lo scavo della palafitta di Ledro in Trentino, venuta alla luce nel 1929: è un altro tassello nella carriera di un archeologo di prim’ordine.
Le scoperte in Valcamonica, prive di risonanza sull’archeologia italiana ufficiale del tempo, non passarono inosservate in Germania. Leo Frobenius, direttore dell’Institut für Kulturmorphologie di Francoforte sul Meno, noto studioso di arte preistorica ed etnografica, in particolare africana, infatti, nel 1935 invia in Valcamonica Erika Trautmann, fotografa e disegnatrice: un’interessante figura di ricercatrice, pesantemente legata a stereotipi di genere (assistente, cooperatrice e persino amante). La Trautmann, in realtà, anche grazie alla sua stretta amicizia con Hermann Göring, non solo si rivela essere la forza motrice delle campagne di rilevamento dei petroglifi camuni, ma anche un’abile procacciatrice di fondi per le ricerche poi condotte, dal 1936, con Franz Altheim, a cui si devono le pubblicazioni di quegli anni.
Franz Altheim era uno storico della religione romana e dell’Antichità, e coltivava anche interessi filologici. Dal 1937 professore all’università di Halle, divenne membro, insieme alla Trautmann, della Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe (“Società di ricerca dell’eredità ancestrale tedesca”), una sorta di associazione culturale delle SS che aveva lo scopo di dimostrare l’origine ariana, vale a dire indo-germanica, della civiltà. Riottenuta nel 1948 la cattedra di Halle, passò due anni dopo alla libera università di Berlino come professore di Storia Antica, dove insegnò fino al 1965, anno del suo ritiro. I materiali prodotti nelle missioni 1935-1937 sono tutti conservati nel Frobenius Institut e rappresentano un archivio eccezionale per la storia delle ricerche. La seconda campagna promossa dall’istituto, oltre a Trautmann, Altheim, e ad altre disegnatrici, vede anche la partecipazione di Károl Kerényi. I tedeschi sono condotti sulle rocce proprio da Longino Amaracco, poi rinnegato e accusato da Marro proprio per questo. Una terza missione dell’Institut für Kulturmorphologie di Francoforte viene condotta in Italia da Douglas C. Fox nel 1937 e completa la documentazione per l’ente tedesco, poi pubblicata da Maria Weyersberg nel 1938. Altheim e Trautmann, invece, proseguono le ricerche autonomamente ed entrano addirittura a far parte della Deutches Anhenerbe di Himmler, organo culturale nazista nato con lo scopo di dimostrare l’origine ariana della civiltà.
Sono ben sei i lavori sulla Valcamonica, dati alle stampe congiuntamente tra 1937 e 1943. Notevoli sono le scoperte della missione nell’area delle Scale di Cimbergo, ma anche la segnalazione, su una roccia di Naquane (la numero 70), del grande personaggio con corna di cervo, poi riconosciuto come Kernunnos da Jacobstahl, nonché la rosa camuna a svastica, scoperta e fotografata per la prima volta da Erika Trautmann nel 1936 a Bedolina. Anche gli studiosi germanici cercano di individuare una cronologia delle incisioni; sulla scia delle ricerche italiane, però, datano alla prima età del Ferro le prime attestazioni di arte rupestre. La loro ricostruzione storica è però vittima di pesanti condizionamenti ideologici, non diversi da quelli fascisti: a differenza di Marro, che sosteneva strenuamente la tesi di un’autoctonia italica, poi generatrice della grandezza dell’Impero di Roma, Altheim, invece, utilizzando il confronto diretto con l’arte scandinava, arriva a sostenere l’origine indo-germanica delle popolazioni locali, note nelle fonti come Euganei. La maggiore antichità delle rocce scandinave, i segni alfabetici simili a quelli runici, la presenza di una divinità legata al disco solare, insomma, tutto sembrerebbe indicare una migrazione diretta degli ariani che avrebbero poi forgiato addirittura la civiltà romana. Sulle rocce di Valcamonica, quindi, nascono anche giochi di potere nell’ambito delle istituzioni culturali di regime per definire le origini dell’identità europea.
La Seconda Guerra Mondiale segna un passaggio ad un nuovo periodo: Marro, senatore del Regno sin dal 1939, pur riproponendo tra il 1945 e il 1947 ulteriori riflessioni sull’arte rupestre, di fatto viene emarginato dal mondo accademico; Altheim, invece, ripresa la sua posizione accademica, non accenna più se non sporadicamente alle campagne camune; Erika Trautman, di fatto, viene esclusa dalla ricerca nella Repubblica Federale di Germania, anche se continua a collaborare con Altheim. A livello europeo, alcune tesi di Altheim vengono discusse, e criticate, negli anni Quaranta, da importanti studiosi dell’epoca, quali Paul Jacobstahl e Pierre Lambrechts.
Nel 1948, lo studio sulle figure di costruzione ad opera di Gabriella Manfrin Guarnieri, allieva di Raffaello Battaglia, riporta l’attenzione sulla Valcamonica, dato che viene pubblicato sulla prestigiosa «Rivista di Scienze Preistoriche» fondata da Paolo Graziosi; ritrovamenti importanti a Seradina e Paspardo si devono a Pietro Leonardi dell’Università di Ferrara. Battaglia torna in Valcamonica nel 1953, chiamato da Giuseppe Bonafini, affinché studi e pubblichi il Masso di Borno, appena rinvenuto (pubblicato insieme ad Acanfora nel 1954). Battaglia, nel 1957, pubblica anche il Masso di Ossimo, sempre scoperto da Bonafini, ma sfortunatamente, nel 1958, il grande studioso scompare prematuramente, lasciando però l’archivio sulle sue ricerche in valle alla famiglia Bonafini, che ancora oggi lo custodisce.
Gli studiosi, a partire dal dopoguerra, possono veramente contare su una guida locale: Battista Maffessoli, giovane capontino appassionato sin dall’infanzia di incisioni rupestri ed eccezionale esperto di luoghi e siti. Figura eclettica e complessa di artigiano, pittore e scultore, Battista, detto Pitoto, porta sulle rocce migliaia di turisti, ma anche decine di studiosi, anche stranieri, quali Hercli Bertogg, Peter Vilhelm Glob, Raymond Christinger, Gehrard Radke; con alcuni di loro nasce un duraturo rapporto di stima e amicizia. Maffessoli realizza anche accuratissimi calchi in gesso di figure e intere rocce affinché il ricco patrimonio rupestre camuno possa essere conosciuto altrove.
I primi anni Cinquanta, tuttavia, non sono immuni da polemiche: una guerra al vetriolo, soprattutto sulla priorità di scoperta di alcuni siti, come il Coren de le Fate a Sonico, si consuma tra l’allieva prediletta di Marro, Savina Fumagalli, sostenitrice assidua delle tesi del maestro, e il “gruppo bresciano”, nato in seno al “Gruppo Naturalistico Regazzoni” legato a Laeng e poi allargatosi al Museo di Scienze Naturali di Brescia, l’esponente di punta del quale è sicuramente il milanese Emanuele Süss, direttore del museo. Il gruppo bresciano, composto per la maggior parte di studiosi di scienze naturali, si pone sin dal 1950 il problema della tutela delle aree incise. Grazie al supporto di Bonafini, Ispettore della Soprintendenza e sindaco di Cividate, e la guida di Battista, il gruppo compie numerosi ritrovamenti e si prodiga affinché nel mondo bresciano il vasto patrimonio camuno sia conosciuto e divulgato. Nel 1954, Laeng, esperto del territorio, individua incisioni di grande importanza sulla collina di Luine, sopra Boario Terme: l’area conosciuta si amplia e si arricchisce con un altro complesso straordinario. Durante le successive esplorazioni nella zona delle Crape, gli studiosi bresciani portano con loro un ragazzino di Gorzone, Giovanni Marini, poi collaboratore di Emmanuel Anati, appassionata guida e strenuo custode del parco di Luine sino alla sua prematura scomparsa.
Sempre nel 1954, Laeng e Süss organizzano una grande mostra sulle incisioni rupestri della Valcamonica al Museo del Castello di Brescia. L’evento richiama decine migliaia di visitatori e consacra definitivamente la fama dell’allora defilata valle bresciana. L’allestimento è curato nei minimi particolari: oltre ai disegni che illustrano le tematiche incise, grazie ai numerosi e meravigliosi calchi in gesso, alcuni dei quali opera di Battista Maffessoli, il pubblico può acquisire una conoscenza reale e percepire il grande valore dell’arte rupestre. In quegli anni, Emanuele Süss si adopera per redigere una cartina delle rocce istoriate nell’area di Naquane e Ronchi di Zir. Süss sa che già Raffaello Battaglia aveva provveduto, negli anni Trenta, a segnare con numeri i lastroni, cifre ormai illeggibili negli anni Cinquanta; la precisa mappatura delle 93 rocce rinvenute nella zona contribuisce ampiamente alla tutela del luogo e la numerazione viene conservata ancora oggi nel parco di Naquane, istituito a partire dal 1955 grazie all’intervento del soprintendente Mario Mirabella Roberti. All’anno successivo, il 1956, risale la prima bibliografia sulle incisioni rupestri camune, sempre ad opera di Süss, mentre Bonafini ripercorre le stesse tappe storiche in un intervento al Primo Convegno di Preistoria del Bresciano.
In tutto questo fervore legato alla divulgazione e alla valorizzazione, sfociato addirittura in un pionieristico video, le scoperte di Laeng e dei suoi si susseguono. Emanuele Süss dedica inoltre particolare attenzione alla segnalazione e alla pubblicazione di nuove iscrizioni in alfabeto camuno, dato che sembra confermare la sua convinzione che le incisioni, per la maggior parte, datino alla tarda età del Ferro, se non addirittura al primo periodo romano: questa impostazione di Süss nei confronti dell’arte rupestre camuna raggiunge definitiva maturazione nel 1958, anno in cui vede la luce una monografia divulgativa con ottime fotografie e un breve saggio introduttivo. A seguito dell’enorme valore dell’arte rupestre camuna, Emanuele Süss si attiva per creare un centro di studi dedicato alla zona, ma con sede a Brescia e con il possibile appoggio dell’Ateneo Bresciano.
Nel 1956, tuttavia, l’intera storia delle ricerche è destinata a cambiare per l’arrivo del ventiseienne Emmanuel Anati. Laureatosi in Geografia all’Università Ebraica di Gerusalemme, e diventato allievo di Henri Breuil nel 1954, Anati era alla ricerca di confronti per il Monte Bego, suo campo specifico di ricerca. Giunto in Valcamonica e grazie alla guida di Battista Maffessoli, il giovane e brillante studioso si rende subito conto dell’eccezionale patrimonio raffigurato sulle rocce. Negli anni seguenti, pur continuando gli studi con Raymond Vaufrey a Parigi, si sposta tra Harvard, Oxford e Londra.
Dal 1957 al 1959, la Missione Anati porta in Valcamonica i primi studenti attivamente coinvolti nelle attività di rilevamento e classificazione. Sin da subito, appare chiaro come l’approccio di Anati al fenomeno rupestre segni un deciso punto di svolta rispetto ai metodi tradizionali, sia in teoria che dal punto di vista pratico, in grado di rivoluzionare le conoscenze e di porre le basi per un approccio scientifico ancora oggi imprescindibile. Il giovane studioso si applica sin da subito a documentare sistematicamente intere superfici, e non solo singole scene; elabora un sistema di schedatura standard sempre più preciso che possa servire per raccogliere i dati e catalogarli; affianca alla documentazione fotografica il rilievo manuale delle superfici (dapprima, dopo averle evidenziate in gesso, riprodotte a mano libera a partire da una quadrettatura, poi a contatto mediante fogli trasparenti e, dalla fine degli anni Sessanta, chine o pennarelli indelebili); presta particolare attenzione alle sovrapposizioni, in modo che sia evidente una vera e propria stratigrafia rupestre, utilissima in termini di cronologia relativa; classifica in diversi stili le figure per permettere una cronologia assoluta, supportata dal continuo confronto con materiali archeologici comparabili (incisioni di armi, determinati ornamenti o rese grafiche, etc..); per finire, cerca di interpretare le scene simboliche e quelle narrativo-descrittive sempre sulla base di parallelismi con le culture limitrofe.
I primi risultati di queste straordinarie innovazioni metodologiche sono visibili sin dalle prime missioni svolte sul campo da Anati, tra il 1957 e il 1959, col supporto di studenti, appassionati e volontari: nel 1957, a Paspardo, vengono individuate le due straordinarie composizioni su parete al Capitello dei Due Pini, in località Plas, che evidenziano analogie con i massi rinvenuti a Cemmo, a Ossimo e a Borno e subito ne viene data notizia sul Bullettino di Paletnologia Italiana. Per imprimere una decisa svolta allo studio dell’arte rupestre, l’intero gruppo della Missione Anati s’impegna nel rilievo integrale e nello studio della Grande Roccia di Naquane, poi oggetto della sua tesi di dottorato nel 1959 e pubblicata nel 1960 nella prestigiosa collana dell’Institut de Paleontologie Humaine. Contemporaneamente all’attività di pubblicazione scientifica, Anati si prodiga anche per divulgare in tutta l’Europa l’arte della Valcamonica: La Civilisation du Valcamonica del 1959 viene ben presto tradotto per i lettori americani, inglesi e italiani (ma l’edizione italiana, del 1964, è la più recente). L’opera viene anche tradotta, per il pubblico americano, con il titolo Camonica Valley, a Depiction of Village life in the Alps from the Birth of Christ as Revealed by Thousands of Newly Found Rock Carvings (1961) e pubblicata presso la prestigiosa casa editrice Alfred Knopf. Grazie a questi saggi, Anati riesce ad ampliare a livello internazionale la fama delle incisioni camune. È proprio in quest’opera che per la prima volta le incisioni rupestri vengono suddivise in un sistema di stili e periodi dal così detto Protocamuno alla romanità. Ecco, quindi, che anche la cronologia dell’arte rupestre viene rivoluzionata e, finalmente, viene respinta la tradizionale datazione delle istoriazioni più antiche all’età del Ferro. Tale classificazione, suddivisa in quattro stili principali (I-IV), e la datazione verranno messe a fuoco sempre più dettagliatamente, con fasi e sottofasi, fino a una formulazione pressoché definitiva nel 1975.
Si susseguono i ritrovamenti: nel 1961, viene ‘ri-trovata’ (dopo secoli!) la Roccia delle Alabarde ai Corni Freschi di Darfo. In realtà, nel giugno del 1462 il masso viene chiaramente indicato in un’annosa questione confinaria tra gli abitanti di Erbanno, Gorzone ed Angolo: la linea di confine, secondo gli abitanti di Erbanno, passava infatti fino alla croce infissa in Cornu delle Falx, et ab ipsa cruce deli Falx. Questa straordinaria scoperta archivistica, pubblicata da Federico Troletti nel 2015, apre un altro filone della storia degli studi: quanto ancora giace inesplorato tra i documenti conservati negli archivi parrocchiali e comunali?
Nuove superfici vengono alla luce a Luine (1962), si esplora l’area di Sellero, che restituisce le prime immagini dell’“Idolo” e della grande rosa camuna a svastica, datate 1963; nello stesso anno, viene rinvenuto un nuovo masso a Bagnolo di Malegno. La riflessione sulle così dette “statue stele” porta lo studioso, proprio in questi anni, a confermare l’ipotesi iniziale che tali monumenti siano da collocare nell’età del Rame, soprattutto grazie ai confronti con i pugnali a lama triangolare rinvenuti nella necropoli bresciana di Remedello Sotto; i massi, quindi, sono il fossile guida per comprendere il fenomeno rupestre calcolitico e la sua simbologia.
Un’altra importante intuizione nata in questi anni è quella di ampliare la conoscenza sulla civiltà camuna attraverso lo scavo archeologico. Grazie alla proficua collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità, Anati ottiene il permesso per aprire, nel 1962, ben due cantieri: il primo, con tre saggi attorno ai massi di Cemmo, mette in luce allineamenti di grandi pietre tra i massi e chiarisce che i massi erano stati incisi poco dopo il crollo della parete retrostante; il secondo, al Dos dell’Arca, rivela invece un antico insediamento fortificato, con incisioni rupestri, frequentato tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro. Dos dell’Arca ha restituito una messe di materiali assai interessanti, e, per la prima volta, una forma di boccale di tipo retico, appartenente a una facies culturale specifica dell’età del Ferro, estesa sino alla Valtellina e alla valle del Chiese.
Nel 1964, una cordata di enti locali capitanata dall’allora sindaco di Capo di Ponte, Giovan Battista Belotti, garantisce finalmente una sede stabile, costruita dal BIM (Bacino Imbrifero Montano), per la Missione Anati: nasce il “Seminario e Centro Camuno di Studi Preistorici ed Etnologici”, poi abbreviato in “Centro Camuno di Studi Preistorici”, un ente indipendente, legato al territorio, che per decenni rappresenterà una scuola di formazione per tantissimi studiosi e giovani e appassionati di preistoria. I primi studenti stranieri provengono dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna; il CCSP programma attività regolari: campagne di ricerca, pubblicazioni specifiche (la collana “Archivi”, il cui primo volume sulla Valtellina è del 1967), riviste (il primo BCSP è del 1964-65), conferenze, convegni (il primo Valcamonica Symposium è del 1968), mostre (nel 1964 a Brescia, nel 1966 a Milano). Il Centro promuove sia studi tematici (come l’importante volume di Anati sui pugnali nell’arte rupestre e nelle statue-stele, del 1972), sia pubblicazioni integrali di area. La bellezza delle rocce e del parco di Naquane è pienamente valorizzata da uno splendido volume illustrato dalle fotografie di Fulvio Roiter (1966). Verso la fine degli anni Sessanta l’area di Luine viene sistematicamente indagata; l’impiego del trattamento neutro permette la messa in luce di molte incisioni rovinate a causa della degradazione delle superfici.
Il decennio successivo richiama in Valcamonica studiosi e ricercatori illustri da tutto il mondo; la vocazione didattica del CCSP, unita all’ambiente internazionale, stimolante e all’avanguardia nella ricerca forma generazioni intere di giovani archeologi, esperti di arte rupestre e funzionari preposti alla tutela delle antichità. Tra gli studiosi di questa prima generazione, approdata in Valcamonica alla fine degli anni Sessanta, hanno sicuramente rilievo Paul e Martine Van Berg Osterrieth, autrice di un’importante monografia sui carri, Giuliana Sluga, che pubblica lo studio su Dos dell’Arca, e Paola Meller Padovani, attiva sia a Seradina che a Nadro sulla roccia 30 e negli scavi dell’area.
Gli anni Settanta si aprono con la monografia sulla Mappa di Bedolina di Miguel Beltran Lloris, nel 1972, e con la chiusura dei cantieri nell’area di Luine (1973, poi pubblicata da Anati nel 1982), anche indagata con sondaggi di scavo. Luine si rivela il maggior polo di arte rupestre della bassa Valcamonica, con un’incredibile escursione cronologica che va da incisioni antichissime di grandi animali (ora datate al Paleolitico Superiore) a scene simboliche di grande impatto con schiere di armi risalenti alla prima età dei metalli sino all’età del Ferro e alla modernità. Il grave stato di degrado delle rocce impone che si tuteli l’area, e nel corso degli anni Settanta viene istituito il Parco Comunale di Luine. Nel 1975, con il fondamentale saggio Evoluzione e stile nell’arte rupestre camuna, Anati fissa definitivamente gli estremi di una cronologia che, con i dovuti aggiustamenti, è però valida ancora oggi ed è servita come modello per tutti gli altri siti rupestri alpini.
Le attività si susseguono freneticamente, tra le cadenze biennali dei Valcamonica Symposium e l’apertura di nuovi cantieri. Dai primi anni Settanta vengono a studiare in Valle Raffaele de Marinis, Marco Tizzoni, Tiziana Cittadini, Giuseppina Tanda, Anna Maria Zanettin, seguiti da Filippo Maria Gambari, Luigi Malnati, Francesco Fedele e, in seguito, Umberto Sansoni, Patrizia Frontini, Mila Simões de Abreu, e successivamente, Silvana Gavaldo. Tra gli appassionati, non si possono dimenticare Giancarlo e Amalia Zerla. L’area delle Foppe di Nadro è oggetto di un lavoro sistematico di esplorazione, scavo e rilievo, iniziato nel 1971 e protrattosi sistematicamente sino al 1983: delle numerose rocce venute alla luce si rilevano integralmente le superfici, si redigono cataloghi, si studiano settori e scene (impossibile non ricordare “il Tempio di Nadro”, “il culto dell’Idolo Farfalla”, “il culto dei cani”, la “Cometa”, una delle prime scene di accoppiamento sessuale…); Foppe in quegli anni è il fulcro delle ricerche e si dimostra subito ricchissima di numerose scene complesse. Viene riscoperta, nel 1976, anche la composizione monumentale su masso della roccia 30, già fotografata dal Marro; nel contempo, esplorazioni di carattere più strettamente archeologico portano all’individuazione di un castelliere (1974), mentre scarsi sono i risultati dei sondaggi attorno alla roccia 30; tuttavia, nel 1977 avviene la straordinaria scoperta del Riparo 2, che ha restituito reperti mesolitici, una sepoltura rituale dell’età del Rame, ceramiche e strutture del Ferro.
A metà degli anni Settanta, il numero crescente di visitatori, soprattutto scolaresche, porta anche gli enti locali a promuovere il territorio, allestendo pannelli e preparando sentieri. Anche per il parco di Naquane si pubblica una guida illustrata, scritta da Vincenzo Fusco e Mario Mirabella Roberti; nel frattempo, la Pro Loco di Capo di Ponte si attiva per i servizi di guida. Nel 1977, il Comune di Ceto apre il Museo di Nadro. Le straordinarie attività del cantiere, tuttavia, non portano alla pubblicazione integrale dell’area, ma solo a quella di rocce singole, come la numero 35 (Umberto Sansoni, 1981). La necessità di tutelare e conservare le scoperte porta il CCSP a chiedere agli enti locali l’istituzione di un parco archeologico: è il primo passo per l’istituzione, nel 1983, della Riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo. Nel 1976-1977 un altro scavo, nella località Le Sante di Capo di Ponte, restituisce ceramica dell’età del Ferro, con materiali combusti e resti ossei, dapprima interpretati come una necropoli; il rinvenimento di un luogo di offerta simile presso il santuario di Minerva porterà Serena Solano a rileggere il sito come un rogo votivo nel 2010.
Nel 1977 arriva al CCSP Francesco Fedele che individua numerosi siti archeologici tra Breno e Capo di Ponte, per poi dedicarsi alle ricerche al Castello di Breno negli anni Ottanta. Nel frattempo, Aldo Luigi Prosdocimi (tra il 1965 e il 1971) e Alberto Mancini (1980) riprendono gli studi sulle iscrizioni e sulla lingua camuna e contribuiscono a inserire le poche testimonianze pervenute nell’ambito del dibattito scientifico contemporaneo. L’immensa risonanza delle scoperte, le collaborazioni internazionali, i contatti con le istituzioni europee e internazionali determinano la candidatura dell’arte rupestre della Valcamonica nella World Heritage List dell’Unesco: è il primo titolo italiano a essere inserito come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, nel 1979, ed è il riconoscimento definitivo dell’eccezionale valore delle incisioni.
La grande stagione degli anni Settanta ha il suo definitivo coronamento nel 1982 con la mostra I Camuni: alle radici della civiltà europea alla Triennale di Milano, seguita dallo splendido volume riccamente illustrato. Da quel momento, le ricerche di Anati modificano la propria direzione e si rivolgono, piuttosto, al tentativo di decodificare i messaggi proposti dall’arte rupestre: lo studioso inizia così a svolgere campagne sistematiche all’estero e a raccogliere dati che possano confluire in un archivio mondiale di arte rupestre. È l’inizio dell’archivio WARA, che oggi possiede centinaia di migliaia di fotografie, documenti, disegni e che con la biblioteca del CCSP è una delle maggiori raccolte di dati del settore.
La nuova strada imboccata da Anati nei suoi studi lo conduce a ricercare segni comuni nell’ambito della spiritualità e del linguaggio rupestre nei cinque continenti e i lavori sul campo vengono affidati ai suoi collaboratori: Tiziana Cittadini, Umberto Sansoni, Mila Simões de Abreu. Si aprono quindi più cantieri di rilevamento integrale di intere aree: da un lato, la continua acquisizione di materiali permette l’archiviazione e quindi la conservazione delle testimonianze rupestri; dall’altro, però, emerge drammaticamente la difficoltà, se non l’impossibilità, di procedere alla pubblicazione completa delle medesime zone. L’esempio più lampante è Foppe di Nadro, la cui rilevazione è completata, sotto la guida di Tiziana Cittadini, nel 1983: per una revisione completa in vista della pubblicazione integrale bisognerà aspettare il giro di boa del ventunesimo secolo! Sul versante occidentale della Valle, dal 1981 si avvia un nuovo progetto nell’area di Seradina. Nella zona “del Corno” lavora il gruppo di Sansoni, mentre a Simões de Abreu viene affidata la Roccia Grande, la numero 12, con oltre un migliaio di incisioni. Nel frattempo, nel 1984, con Mila Simões de Abreu come responsabile, il Paspardo Rock Art team inizia lo studio sistematico del territorio di Paspardo, a partire dal Dos Sottolajolo, prima zona catalogata con l’uso del computer. La studiosa portoghese si deve quindi dividere tra versante occidentale e orientale della valle. Mentre al Corno il lavoro si completa, sulla roccia 12 esso prosegue a singhiozzo, finché non viene ultimato nel 1987.
All’interno del CCSP, lo sviluppo di posizioni critiche e di contrasti provoca una diaspora di ricercatori: nel 1987 nasce il Dipartimento Valcamonica e Lombardia del CCSP, diretto da Umberto Sansoni e Silvana Gavaldo, mentre nel 1988 anche Mila Simões de Abreu si allontana dal CCSP e, con Angelo Eugenio Fossati, fonda la Cooperativa Archeologica “Le Orme dell’Uomo”, che avrà come collaboratori Patrizia Frontini, Stefania Casini, Andrea Arcà. Se il Dipartimento sceglie di proseguire sul percorso già tracciato da Anati, la Cooperativa se ne distacca in maniera piuttosto netta, legandosi alle riflessioni critiche mosse da Raffaele de Marinis, un tempo collaboratore del CCSP, poi più attento all’analisi della cultura materiale riprodotta sulle incisioni e a una ridefinizione importante della cronologia anatiana. La pubblicazione integrale di Seradina è vittima di questi anni difficili: la roccia 12 viene ricontrollata e conservata dalla Cooperativa, mentre i rilievi del Corno sono tuttora al CCSP. Solo in tempi recenti, cioè nel 2015, una rinata collaborazione ha permesso di ipotizzare il ritorno al progetto, con un articolo sulla storia degli studi sulla roccia 12. Il frutto della collaborazione tra gli studiosi della Cooperativa e de Marinis porta, nel 1991, alla importante mostra Immagini di un’aristocrazia del Ferro nell’arte rupestre camuna, il cui catalogo è ricchissimo di spunti per nuove riflessioni sulla comprensione delle incisioni dell’età del Ferro.
Mentre la Cooperativa si prodiga, dal 1988, in continuità con le ricerche precedenti, a esplorare la grande area di Paspardo, nota soprattutto per le sue antiche composizioni topografiche e per le figure di grandi guerrieri, ma anche per l’eccezionale ritrovamento, nel 1993, di un’ascia neolitica in pietra verde levigata (una bella e completa sintesi esce in un volume del 2007) e per le straordinarie pitture rupestri (rinvenute nel 1992), il Dipartimento mappa e rileva integralmente le rocce di Sellero, edite nel 1987, anno in cui l’area viene trasformata in Parco Comunale, sempre per l’opera di Tiziana Cittadini; gli studiosi del Dipartimento Valcamonica passano poi al Pià d’Ort, prima area ad essere pubblicata integralmente, per zone e per singole rocce, nel 1995. Nel volume, oltre a saggi dedicati alle varie tematiche, già si apre un dibattito di confronto con le nuove tesi di de Marinis per quanto concerne la cronologia dell’età del Ferro.
Gli scavi archeologici ampliano ulteriormente le conoscenze sulla Valle: tra il 1980 e il 1985, gli scavi di Francesco Fedele al Castello di Breno rivelano una prima occupazione neolitica, con ceramica appartenente a una facies locale (la Cultura dei Vasi a Bocca quadrata 3), una frequentazione nell’età del Rame e insediamenti episodici dalle età del Bronzo e del Ferro fino al Medioevo (Fedele 1988). Sull’altopiano di Ossimo, nel 1988, Giancarlo Zerla, instancabile cercatore di reperti archeologici, rinviene, ad Asinino-Anvoia tre stele dell’età del Rame: Francesco Fedele, che ha intuito le potenzialità dell’area e suggerito a Zerla di esplorarla, ha così l’opportunità di scavare uno straordinario sito cerimoniale intatto (Fedele 1990).
Gli anni Ottanta e Novanta, infatti, sono ricchi di sensazionali scoperte sull’età del Rame; dopo Ossimo, anche l’area cerimoniale di Pat, scoperta nel 1990, viene scavata dalla Soprintendenza con la direzione di Raffaella Poggiani Keller e divulgata in saggi a partire dal 1999. All’inizio degli anni Novanta, Ausilio Priuli scopre altre aree incise a Berzo Demo (segnalate nel 1984) e soprattutto nell’impervia area di Piancogno (pubblicata nel 1993), caratteristica per il prevalente uso del graffito, per le incisioni di guerrieri con scudi a pelle di bue e asce alabarde e per le interessanti testimonianze di epoca romana. Alle raccolte epigrafiche si aggiungono gli studi di Maria Grazia Tibiletti Bruno, che tra il 1990 e il 1992 analizza le nuove iscrizioni camune ma soprattutto gli alfabetari; quelli di Alessandro Morandi, sempre sul camuno (1998 e 2004) e il corpus delle iscrizioni latine, dato alle stampe nel 1991 da Alfredo Valvo. Nel 1989, Fossati, Simões de Abreu e Jaffe compilano una prima sintesi di storia delle ricerche, e aggiornano la bibliografia degli studi già pubblicati, aprendo così una nuova via di ricerca in un campo che, sino ad allora, era tenuto in scarso conto.
Il 1990 segna l’avvio, da parte del Dipartimento, della ricognizione sistematica dell’area di Campanine di Cimbergo, che si protrae sino al 2000, con le ultime scoperte effettuate già in vista della pubblicazione integrale dell’area del 2009. A Campanine, accanto a figure di aratro calcolitiche, a un carro dell’età del Bronzo, a possenti figure di guerrieri, si avviano anche, ad opera di Cristina Gastaldi e Federico Troletti, ricerche sulle incisioni di epoca storica, sino ad ora trascurate. L’area restituisce, pure, delle pitture rupestri, già individuate nella vicina Paspardo. Nel 1994, inoltre, una campagna di ricognizione fotografica e un catalogo preliminare restituiscono la ricchezza del patrimonio rupestre storico sulla collina del Monticolo di Darfo, poi oggetto di studio da parte di Federico Troletti tra il 2013 e il 2015. Accanto al BCSP, dal 1993 le NAB (Notizie Archeologiche Bergomensi) e in seguito il BEPAA (Bulletin d’Études Prehistoriques et Archeologiques Alpines) diventano un punto di riferimento costante per gli studiosi. La Cooperativa, in questi anni, si prodiga nell’organizzazione di convegni, volti ad aggiornare lo stato delle ricerche e ad aprire nuove prospettive negli studi: a Breno, nel 1989, I Camunni tra Storia e Preistoria; nel 1991, Sulle Tracce del Sacro; nel 1992 il primo Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre (poi pubblicati nel secondo volume delle NAB); a Darfo Boario Terme, nel 1997, L’Europa, le Alpi, la Valcamonica – secondo Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre, Darfo Boario Terme (poi pubblicato nel 2001 a Milano).
Il 1994 è l’anno della grande mostra Le pietre degli Dei, organizzata a Bergamo da Stefania Casini e dedicata ai menhir e alle stele dell’età del Rame in Valcamonica e in Valtellina, periodo cruciale nella storia delle Alpi e che ha nei massi incisi un fossile-guida eccezionale; il catalogo offre un panorama completo dei ritrovamenti avvenuti sino ad allora, ma destinati ad aumentare nel corso del nuovo millennio. Tra il 1989 e il 1991 la Soprintendenza affida alla Cooperativa Le Orme dell’Uomo la realizzazione dei rilievi integrali di alcune rocce di Naquane: n. 1 (parziali), 6, 11, 23, 32, 35, 50, 57, 60 (parziali), 70, 73, 99, nell’ambito di un progetto di riallestimento che prevede pannelli illustrativi accanto alle rocce e cinque itinerari interni al parco, iniziato da Raffaele De Marinis e concluso da Raffaella Poggiani Keller. Vennero inoltre eseguiti i rilievi di alcune statue stele (Ossimo 8, Borno 4, Borno 5, Borno 6, Ossimo 4, Ossimo 10, tanto per citare le più importanti). Nel 1991, la Cooperativa “Le Orme dell’uomo”, per commemorare i sessant’anni della prima segnalazione all’estero, diffonde la mostra itinerante Scolpito nel Tempo; nel 1996, infine, seguendo un’intuizione geniale, viene creato «Tracce Online Rock Art Bulletin», il primo bollettino online dedicato alla Rock Art, uno spazio virtuale dove pubblicare i propri scritti sull’arte rupestre, ma anche un luogo di confronto e di aggiornamento permanente.
Durante l’ultimo ventennio, la Valcamonica è stata, come sempre, generosa nel regalare nuove emozioni agli studiosi: l’età del Rame, ad esempio, ha donato nuove composizioni monumentali, ritrovate, purtroppo fuori contesto, a Campolongo di Grevo, a Foppe di Nadro, a Paspardo loc. La Bolp, a Cevo e Malegno; gli scavi a Cemmo, attuati dalla Soprintendenza alle Antichità a partire dal 2000, hanno rivelato un sito cultuale calcolitico di lunghissima frequentazione e dalla complessa tessitura, dipanatosi attorno ai due massi principali. Tali acquisizioni arricchiscono, insieme alle nuove scoperte su roccia a Paspardo e a Foppe di Nadro, un panorama già eccezionale per testimonianze e contesti.
Nel frattempo, i sempre più pressanti problemi legati alla tutela e alla necessità di mappare le superfici impongono una sistematica georeferenziazione di tutte le aree incise: è Il Progetto “Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del Sito Unesco N. 94 Arte Rupestre Della Valle Camonica”, promosso da una legge del 2006. Decine di ricercatori rintracciano, georeferenziano, constatano la conservazione, fotografano e compilano schede digitali per ogni singola roccia incisa che sia stata segnalata nel corso degli anni: l’immane lavoro viene pubblicato in sintesi nel 2013, a cura di Raffaella Poggiani Keller e Giuseppina Ruggiero.
Ma torniamo alla storia: mentre a Paspardo continuano le campagne estive, la Cooperativa organizza gli importanti convegni Le Pietre degli Dei a Brescia (nel 2004, in collaborazione con il Museo archeologico di Bergamo e l’Università Cattolica di Brescia; NAB 12); Paspardo tra Castagni e Incisioni Rupestri (2006, poi pubblicato nel 2007); per terminare, il convegno dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP), L’arte Preistorica in Italia, tenutosi nel 2007 a Trento e in Valcamonica (atti pubblicati in Preistoria Alpina n. 46, 2012).
Negli stessi anni, il Dipartimento Valcamonica apre un nuovo cantiere di ricerca in Bassa Valcamonica, nell’area di Pisogne e Piancamuno, ricca di “segni minori”, cioè di arte schematica, coppelle, figurazioni di età storica quali date, croci, incisioni correlate all’attività mineraria; i ritrovamenti, divulgati nel 2001, offrono lo spunto per analizzare anche le caratteristiche dell’intero territorio, sia dal punto di vista etnografico che da quello archeologico. Nel 2004, è l’area di Grevo a essere pubblicata, con la stessa attenzione per la storia del territorio, all’arte schematica e alle testimonianze più recenti; ed è proprio in questa area che, nell’estate del 2001, si rinvengono i quattro frammenti di statue menhir di Campolongo, studiati da Alberto Marretta. Nel 2001 si inizia il cantiere di Zurla, che in tre anni porta alla luce numerose rocce con armati, figure circolari con complesse campiture interne e l’unico alfabetario a martellina in alfabeto epicorico; dal 2004 è la volta dei Verdi, piccola zona con poche rocce; nel 2005 la ricerca si sposta nell’area di Pagherina-Dos del Pater. Il Dipartimento torna a Foppe per vari ricontrolli e completamenti dei rilievi eseguiti tra gli anni Settanta e Ottanta, in vista della pubblicazione integrale di area, mentre continuano le campagne anche a Pagherina e Dos del Pater. Dopo il 2006, insieme al lavoro a Foppe, l’équipe del CCSP si muove in varie località tra Foppe e Naquane, come Boscatelle (dal 2007) e Ronchi di Zir (nel 2011), mentre i risultati delle esplorazioni in valle di Saviore vengono pubblicati nel 2006. Nel 2005 vengono alla luce altre due grandi rocce con mappe a Bedolina e a Ronco Felappi, sul versante occidentale. Alberto Marretta, con Serena Solano, scopre altre superfici nell’area di Loa, nel comune di Berzo Demo, fittamente incise con iscrizioni in alfabeto epicorico. Nel 2009, infine, B.S. Hansen scopre, nella forra del Re in territorio di Paspardo, una parete verticale con pitture rupestri con cavalieri e antropomorfi dell’età del Ferro.
Nei primi anni Duemila, inoltre, gli studiosi del CCSP e quelli della Cooperativa “Le orme dell’Uomo” iniziano un riavvicinamento, pur nel rispetto delle reciproche differenze. I risultati delle campagne a Paspardo sono di nuovo pubblicati sul BCSP, così come articoli specialistici e recensioni di testi. Gli anni successivi al 2005 vedono un grande fiorire di pubblicazioni: lo studio di Andrea Arcà su Dos Cuì (2007); le sintesi di Marretta su Foppe di Nadro (2004) e Campanine di Cimbergo (2007); lo studio integrale, a cura di Umberto Sansoni e Silvana Gavaldo, dell’area di Campanine (2009); la sintesi delle ricerche a Paspardo (2007), a cura di Angelo Eugenio Fossati; la pubblicazione della Grande Roccia di Naquane, sempre a cura di Andrea Arcà (2013); il grande catalogo della mostra sull’età del Rame, a cura di Raffaele de Marinis (2013); la pubblicazione delle rocce dell’area di Berzo Demo (Marretta-Solano 2014), i primi volumi di catalogo sulle Foppe di Nadro (2017-2019), solo per citare i più importanti, oltre, naturalmente, a una grande quantità di articoli, saggi e studi specifici che attestano ancora la piena vitalità della ricerca sul campo.
Continuano, naturalmente, i Valcamonica Symposium: grazie alla rinata collaborazione tra le scuole di ricerca, sia il convegno Santuarios (2016) che il prestigioso congresso di IFRAO (2018) vengono ospitati in Valcamonica. Anche la storia degli studi ha prodotto ulteriori opere di sintesi, come gli atti dell’incontro sulla storia delle ricerche tenutosi a Capo di Ponte nel 2005 e il catalogo legato alla mostra storica sul centenario della prima segnalazione (entrambi pubblicati nel 2009). Per terminare, non è possibile non citare la realizzazione del grande Museo Nazionale della Preistoria a Capo di Ponte, inaugurato il 10 maggio 2014, nel quale non solo i massi istoriati dell’età del Rame hanno trovato una sede, ma nel quale sono finalmente visibili i materiali ritrovati negli scavi archeologici eseguiti nel corso del secolo precedente.